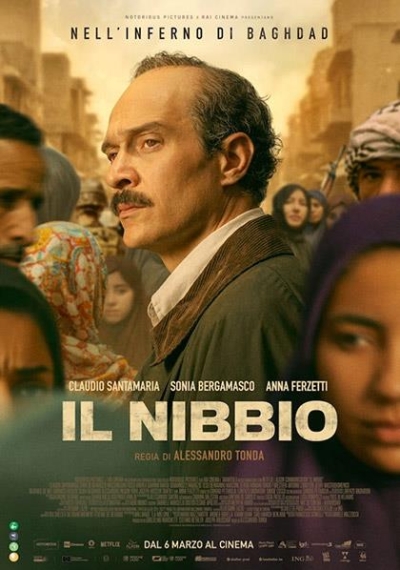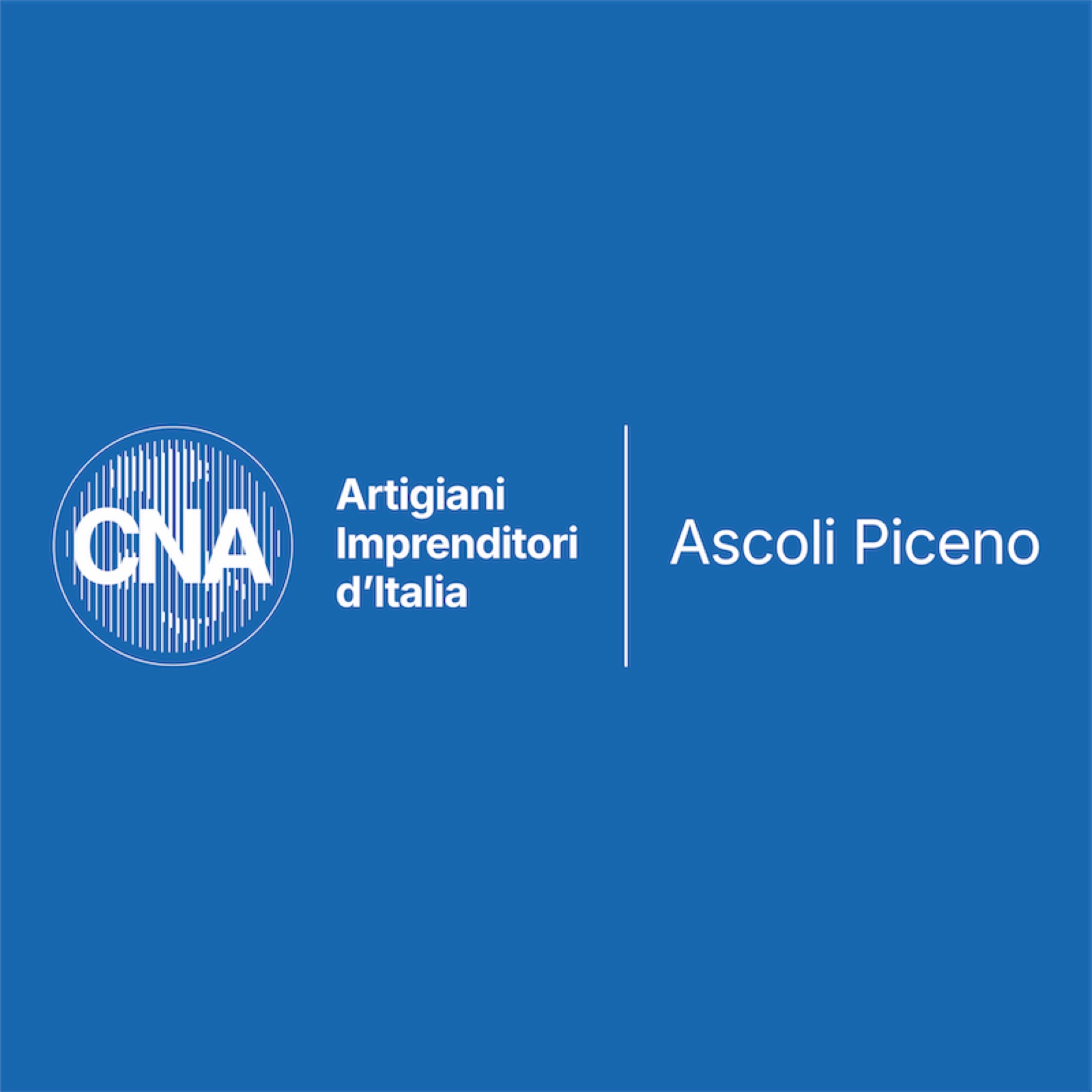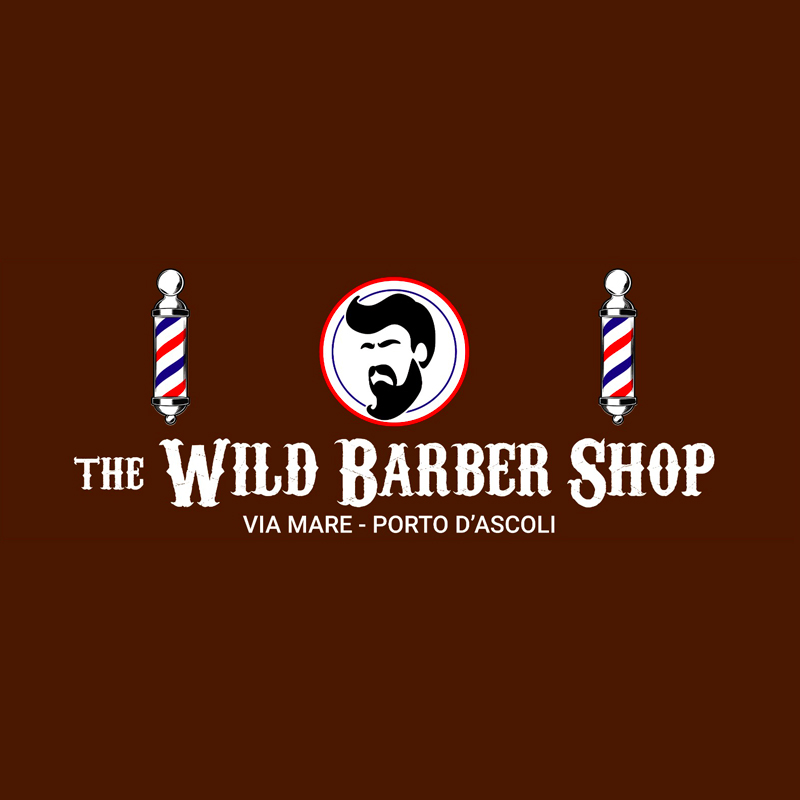La situazione attuale del conflitto israelo-palestinese continua ad essere estremamente complessa e dolorosa. Cosa ne pensi, a partire dalla tregua per il rilascio degli ostaggi?
La tregua è senza dubbio un dato positivo, perché ogni volta che tacciono le armi è sempre un segnale importante. Avere smesso di combattere fa tirare un sospiro di sollievo. Tuttavia, la tregua non è la pace e questa tregua è estremamente precaria; arriva dopo un anno e mezzo di combattimenti, in cui si sono spezzate tutte le relazioni e la fiducia è venuta completamente a mancare. Tantissime esperienze di incontro, di dialogo e quindi di costruzione della pace - portate avanti da associazioni, opere, persone che avevano deciso di scommettere sull’incontro con l’altro - purtroppo sono in gran parte fallite o sono entrate in crisi. Questo rappresenta un problema serio perché dove non si riesce a ricostruire un tessuto sociale coeso, capace di desiderare e volere la pace, anche la politica non potrà mai lavorare realmente in questa direzione. Anche noi siamo preoccupati; Israele ha espulso o bloccato tutte le ONG presenti nel suo territorio e ci è stato detto con chiarezza che, se mai la nostra linea di pensiero dovesse risultare sgradita, saremmo costretti a chiudere. È una tregua estremamente fragile perché i problemi di fondo non sono stati risolti: rimane il problema degli ostaggi e sembra che per Netanyahu la priorità sia distruggere Hamas piuttosto che riportare a casa i prigionieri. Inoltre, la tregua è resa ancora più incerta dai cambiamenti nella politica americana: il ritorno sulla scena di Trump apre molti interrogativi. Perciò guardiamo alla tregua certamente con speranza, ma anche con grande preoccupazione, consapevoli che, se non si pensa a una pace giusta e duratura - per usare le parole di Giovanni Paolo II - qualunque tregua rischia di essere soltanto una pausa tra una guerra e l’altra.
Quali sono, per la vostra esperienza sul campo, gli ostacoli principali al raggiungimento di una soluzione pacifica e stabile per entrambe le parti?
Le cause che allontanano la pace dalla Terra Santa sono moltissime, soprattutto in un conflitto che dura ormai da più di cento anni, perché, va detto, inizia ben prima del 1948. Oggi, tra le cause più evidenti, c’è da una parte l’intransigenza di Hamas, che continua a non riconoscere la legittimità dello Stato di Israele. Dall’altra parte il governo israeliano guidato da Netanyahu che porta avanti con determinazione la volontà di distruggere completamente Hamas se non addirittura di sopprimere lo Stato Palestinese. Questo compromette qualsiasi prospettiva di pace. Accanto a queste dinamiche più recenti, rimangono irrisolte questioni storiche come, ad esempio, quella di Gerusalemme che entrambe le parti considerano capitale del proprio Stato; gli insediamenti in Cisgiordania; la divisione interna della leadership palestinese, tra Hamas e l’Autorità Palestinese, che rende difficile individuare un interlocutore chiaro con cui trattare. I tentativi di pace del passato sono falliti perché anche due leader di buona volontà, come furono Rabin e Arafat, se non hanno un popolo dietro che desidera davvero la pace, non possono ottenere risultati duraturi. Per questo occorre lavorare sulla società, e tutto deve partire dall’educazione. Purtroppo, oggi le scuole, da entrambe le parti, sono strumenti di propaganda: insegnano ad odiare, a disprezzare l’altro. Servono invece persone, esperienze, scuole che insegnino ad amare l’altro, a riconoscere nell’altro un compagno di cammino, un alleato nella costruzione della pace. Israele e Palestina, israeliani e palestinesi, sono condannati a vivere insieme; se continueranno a crescere in un sistema educativo che insegna solo l’odio, non ci sarà mai nessuna possibilità reale nemmeno di immaginare la pace.
Quali sono le principali difficoltà che la popolazione civile affronta quotidianamente in questi luoghi di guerra?
La popolazione civile naturalmente affronta la guerra in modo diverso, perché differenti sono le condizioni in cui vive. I palestinesi di Gaza non hanno più nulla. Da mesi sono nella privazione più assoluta: Israele ha bloccato l’acqua, l’elettricità, l’ingresso degli aiuti umanitari, e questo ha reso la vita non solo disperata, ma quasi impossibile. A Gaza, il 90% delle infrastrutture è stato distrutto. Dopo la tregua, molte persone hanno provato a tornare alle loro case, ma nove su dieci non hanno trovato più nulla. È tutto da ricostruire e si parla di una ricostruzione che richiederebbe miliardi e decenni di lavoro. Eppure, nonostante questa situazione drammatica, dalla visita del patriarca Pierbattista Pizzaballa è emerso che la prima richiesta della comunità cristiana di Gaza non è stata “dateci pane o medicine”, ma “ridateci le scuole, vogliamo che i nostri bambini possano tornare a scuola”. Questo dimostra che, accanto a una quotidianità fatta di privazione assoluta, esiste ancora una volontà di guardare al futuro, di sperare. Anche in Cisgiordania la situazione è molto difficile; la popolazione vive nella paura e nell’ansia costante e ci sono continui scontri con i coloni. La Cisgiordania è composta da realtà diverse: città come Jenin e Nablus sono sottoposte a una pressione continua, con situazioni quotidiane insostenibili. E poi c’è Betlemme, che è la culla della cristianità e che viveva grazie al turismo, un’economia completamente distrutta prima dal Covid e poi dalle conseguenze degli attacchi del 7 ottobre 2023. A tutto questo si aggiunge la revoca dei permessi di lavoro per i 50.000 palestinesi che lavoravano in Israele sostituiti da lavoratori indiani. Quei lavoratori palestinesi creavano un punto di contatto, un’occasione di dialogo, di incontro quotidiano con gli israeliani che oggi è venuto meno aggravando ulteriormente la distanza tra i due popoli. E dal lato israeliano? Anche gli israeliani vivono in condizioni difficili, sebbene - bisogna dirlo - c’è dolore e dolore: i profughi di Gaza vivono nei campi, i profughi israeliani vivono negli hotel. È importante non essere neutrali nella descrizione delle condizioni come d’altro canto non vogliamo fomentare lo scontro attraverso il racconto delle sofferenze. Anche gli israeliani vivono nella paura e nel dolore, perché di fatto Israele è un Paese che non conosce la pace e dove la propaganda e la narrazione ufficiale spingono all’odio verso l’altro. E questo è un punto fondamentale: un Paese che viene educato ad odiare non potrà mai vivere in pace, né potrà mai raggiungere quella sicurezza che pure desidera. A questo proposito mi tornano in mente le parole fortissime di Benedetto XVI, durante il suo pellegrinaggio in Terra Santa, quando disse agli israeliani: “Cari amici israeliani, voi cercate la sicurezza, ma ricordate che in ebraico la parola sicurezza ha la stessa radice della parola fiducia. Non può esserci sicurezza se non c’è fiducia”. Ecco, la fiducia: è proprio ciò che si è completamente sgretolato in questo anno e mezzo. La fiducia nel futuro, nell’altro, tra le persone: forse è questa la prima cosa da ricostruire.
Cosa rappresenta la telefonata quotidiana del Papa alla parrocchia di Gaza?
Papa Francesco chiama ogni giorno il parroco di Gaza. Con una fedeltà incredibile, ripete quotidianamente un messaggio semplice ma profondissimo: “Io sono con voi, partecipo del vostro dolore, soffro con voi”. E dice anche: “Sono lì con voi, nella parrocchia, accanto ai malati, ai bambini, agli anziani, a tutti coloro che soffrono”. Questo gesto testimonia l’amore che il Papa ha per quella terra e la sua vicinanza a chi oggi è davvero tra gli ultimi, gli abitanti della Striscia di Gaza, che non hanno più nulla, che non hanno più prospettive, che non sanno più cosa sognare o sperare. Il Papa dice: “Io sono con voi”. E questa è una cosa bellissima, perché è un segno concreto dell›amore di Gesù, che sulla croce ha detto all’umanità: "Io sono con te". Dio non elimina il dolore, ma si fa vicino a chi soffre. Papa Francesco nelle sue telefonate non fa grandi discorsi, ma chiede cose semplici, umane, vere: “Avete mangiato oggi? Come stanno i bambini? C’è l’influenza? Che tempo fa?”. Domande normali, di chi vuole entrare nella vita quotidiana di quelle persone. È la telefonata di un amico, di un padre. Questo, secondo me, è uno dei gesti più belli e più forti di questo pontificato, la testimonianza di un amore grande, di uno che dice: “Io non vi tolgo il dolore, ma lo vivo con voi”, perché insieme possiamo affrontarlo. E questo, in un tempo in cui tutti fuggono dal dolore degli altri, è qualcosa di straordinario.